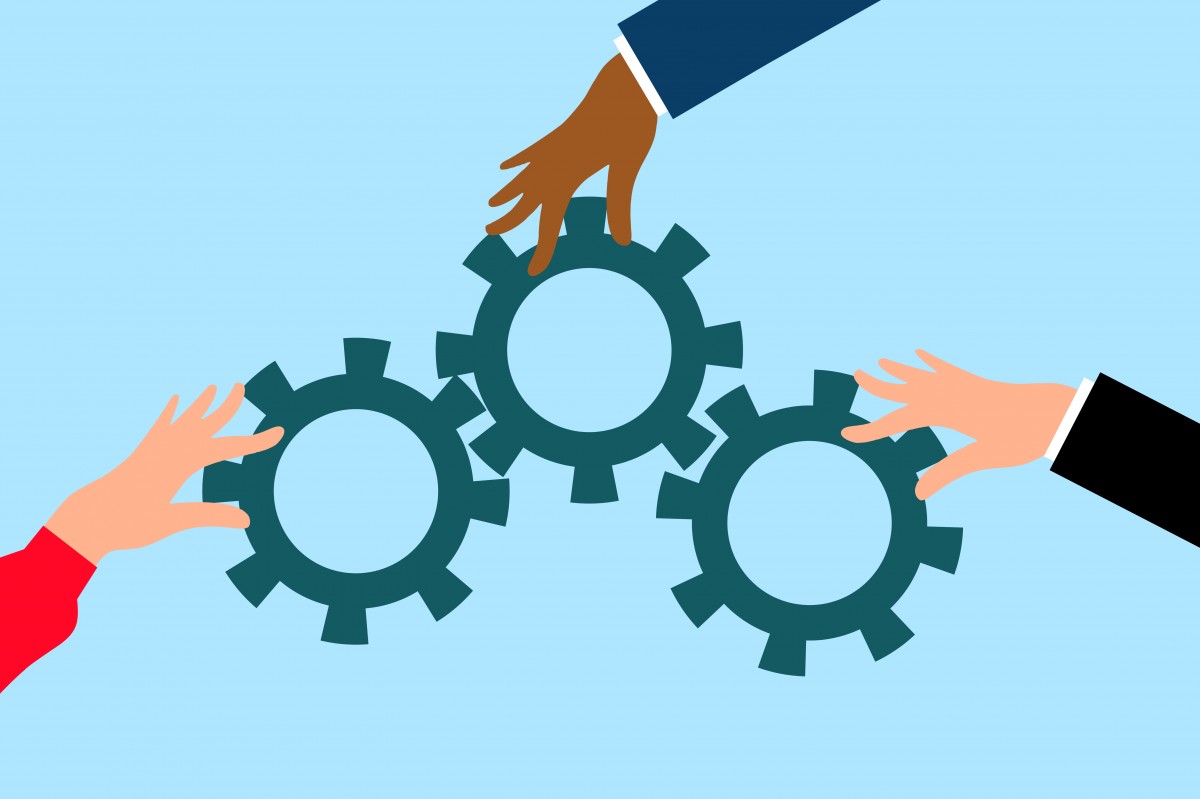Comunismo? Perché non si può ripartire da zero
Giovanni Mazzetti*
Ricordo ancora un giorno di inizio 1990. Stavo su un tram che passava per Porta Maggiore a Roma. Poiché era praticamente vuoto, mi misi a leggere i giornali che avevo appena comperato, cominciando da “L’Unità”. Un viaggiatore che stava per scendere si avvicinò a me e con fare tra l’indignato e il provocatorio, alludendo al crollo del Muro di Berlino, disse: “Ma ancora non vi vergognate!” Non ebbi ovviamente modo di spiegarmi, ma gridai che “No! Non mi vergognavo affatto”. Credevo, infatti, che ci fossero altri comunisti che, come me, non si sentivano affatto trascinati in quel crollo, e che anzi lo consideravano come un’apertura verso il nuovo, della quale c’era un gran bisogno. Oggi, però, a trent’anni di distanza forse un po’ di vergogna dovrei provarla.
Che cos’è infatti la vergogna? “Quel sentimento penoso e umiliante che l’uomo prova dal non essergli ben riuscita un’opera, un’impresa, dall’aver errato, riconoscendo di esserne stata cagione la sua imprevidenza”. Ecco, forse dovrei vergognarmi di aver creduto nell’esistenza di quell’apertura quando in realtà ancora ne mancavano le condizioni. Infatti, mentre era vero che coloro che volevano spingersi oltre l’esperienza precedente erano in molti, ben pochi di loro erano consapevoli delle sofferenze e dell’impegno che ciò avrebbe comportato. I più confondevano la rifondazione comunista con la rifondazione del partito comunista, al quale appartenevano, in contrapposizione ad altri che smaniavano per ridiventare “normali”. Ma la disgregazione di quel partito non era un qualcosa a se stante, ma costituiva piuttosto l’effetto di una crisi profonda che aveva investito la società intera. Per cui non bastava lottare con più forza per cercare di far prevalere il modo di vita per il quale ci si era battuti fino a quel momento, ma di aprire una nuova via verso uno sviluppo che era però tutta da costruire esplorativamente. D’altra parte lo stesso Marx ci aveva messo in guardia proprio su questo versante, sostenendo “che nelle lotte dei lavoratori c’era stata indubbiamente la volontà, ma quasi sempre era mancata la capacità”. In che cosa si concretizzava questa “incapacità”? Nel fatto che troppo spesso la classe operaia aveva cercato di emanciparsi, fallendo proprio perché aveva preteso di realizzare quell’emancipazione “negli stretti limiti delle sue stesse condizioni di esistenza, quasi di soppiatto”1.
È vero che in genere non si può sapere prima di tentare se la capacità manca oppure c’è, perché in genere s’impara facendo. E tuttavia, quando l’evoluzione dimostra che si è fallito bisogna conquistare una distanza dal proprio progetto (bisogno), proprio per non incappare, “facendo”, in una testarda e frustrante ripetizione coattiva del preesistente modo di comportarsi. Ma da che cosa è necessario prendere le distanze oggi? Come provare a riconoscere “i limiti della propria condizione d’esistenza”, per superarli? Facciamoci guidare brevemente da Marx.
Per non presupporre il mondo come un dato
Nel primo capitolo del Capitale, nel tentativo di spiegare la genesi e la natura del rapporto di scambio, che così tanto ha contribuito al nostro sviluppo, Marx constata: gli esseri umani pensano che il denaro sia denaro per sua stessa natura intrinseca. Proiettando in esso il potere che gli attribuiscono nel mediare i loro rapporti cooperativi, lo trasformano in un feticcio. Non capiscono così né come esso abbia preso corpo attraverso il loro stesso sviluppo, né il modo in cui condiziona e, soprattutto, finisce oggi col limitare la loro stessa azione riproduttiva. In una notarella esplicativa a fondo pagina aggiunge: “queste determinazioni della riflessione sono in genere cosa strana. Per esempio un dato uomo è re soltanto perché gli altri uomini si comportano come sudditi nei suoi confronti. Viceversa, essi credono di essere sudditi, perché egli è re”2. A che cosa si riferisce quel “viceversa”? Al fatto che con questo modo di procedere gli esseri umani si “tirano fuori” dal contesto in cui vivono, e cioè rappresentano a sé stessi la condizione di sudditanza in cui si trovano come un dato meramente oggettivo, come un qualcosa che non possono che limitarsi a subire, nonostante in realtà contribuiscano a determinarla. Una dinamica che – lo si capisca o no – si instaura anche nei confronti del denaro, quando la cooperazione si blocca perché “non ci sono i soldi”.
Marx non descrive quest’inversione solo in relazione al rapporto re-suddito. La applica, del tutto coerentemente, anche ai nuovi rapporti sociali che si stavano allora instaurando in Europa tra capitale e lavoro salariato. Il lavoratore, scrive nei Grundrisse, crede infatti di essere tale soltanto perché c’è un padrone. Ciò che è indubbiamente vero. Ma è anche vero il viceversa, e cioè che il padrone è tale solo in quanto e perché egli si rapporta al contesto proprio come un lavoratore. Fintanto che non sa far altro che cercare degli acquirenti per la sua capacità produttiva – attua una transustanziazione3 nella quale la sua soggettività finisce intrappolata. Né più e né meno di come il proprietario privato non sa fare a meno del potere del denaro, il lavoratore, col suo stesso comportamento, pone il padrone (imprenditore o stato) come una componente necessaria del suo rapporto produttivo, appunto perché si batte affinché riproduca quel rapporto di denaro attraverso il quale punta a partecipare al processo produttivo e a riprodurre la sua stessa esistenza.
Che cosa critica il povero Marx nei due passi in questione? Il fatto che, proprio perché l’individuo, nel suo percorso verso l’umanizzazione, si considera “arrivato”, tratta – più o meno consapevolmente – i rapporti sociali a cui partecipa come un qualcosa di esteriore. Non assume cioè su di sé i problemi che lo investono come una manifestazione della sua stessa individualità, del suo modo di rapportarsi al contesto nel quale è venuto al mondo e vive. Se e quando questa situazione determina uno stato di frustrazione, si instaura prima o poi una spinta a superarla. Ma anche qui Marx ci mette in guardia sul nostro stesso modo di procedere. Scrive infatti sulla “Rheinische Zeitung”: “nell’esame delle condizioni politiche si è cercato con troppa leggerezza di non tener conto della natura oggettiva delle situazioni e di far tutto dipendere dalla volontà delle persone agenti. Ma si danno situazioni che determinano tanto le azioni dei privati quanto delle singole autorità, eppure sono indipendenti da quella volontà quanto il sistema respiratorio. Se fin dall’inizioci si pone da questo punto di vista oggettivo, non si riesce ad addossare la buona o la cattiva volontà né all’una, né all’altra parte, ma si constaterà l’imporsi (wirken) di situazioni dove di primo acchito sembrava agissero solo persone. Non appena si sia dimostrato che una certa cosa viene resa necessaria dall’insieme della situazione, non sarà difficile determinare sotto quali condizioni esteriori questa cosa abbia dovuto entrare realmente a far parte della vita e sotto quali condizioni sebbene ne preesistesse il bisogno, non abbia potuto entrarvi”4. Insomma, il lavoratore può anche sentire il bisogno di sottrarsi alla situazione relazionale di subordinazione nella quale si trova, quando questa sfocia in precarietà, impoverimento e disoccupazione, ma la sua volontà di farlo non basta.
Fino a che punto tutto ciò ci riguarda
Veniamo così al punto: qual è lo zero dal quale i comunisti potrebbero sperare di partire oggi, evitando di continuare a macerarsi in una situazione negativa, come accade ormai da decenni? Il riconoscere che prima del comunismo c’è il bisogno di imparare ad agire da esseri umani, cosicché l’uno è il presupposto dell’altro. Quando Marx rimprovera i proletari del suo tempo di “volere una situazione diversa, fermi restando i limiti delle loro condizioni d’esistenza”, li critica per il fatto di non procedere umanamente. Essi vogliono, cioè, che la condizione in cui si trovano, di dipendenza dal capitale, non sfoci negli effetti che conseguono da quel rapporto sociale, ma allo stesso tempo lo vogliono proprio attraverso la riproduzione di quel rapporto, cioè restando lavoratori salariati. E quando cercano di spingersi al di là lo fanno in forma idealistica, cioè fantastica, pensando che la volontà di un “mondo altro”, nel quale le loro sofferenze scompaiono, basti.
Che cosa manca nella loro azione? Che cosa la trasforma nella manifestazione di un’impotenza, invece che di un potere? Manca l’elemento centrale di quella che abbiamo definito come prassi umana. Che cos’è, infatti, che distingue gli umani dal resto del mondo animale? Com’è noto gli animali sanno risolvere i loro problemi riproduttivi, ma sanno farlo solo se le condizioni per risolverli ricadono immediatamente nel loro campo esperienziale. E cioè se esse sono immediatamente date. Non appena queste non sono tali, gli animali si mostrano impotenti e spesso rinunciano a soddisfare il loro bisogno o introducono comportamenti stereotipati.
Ma gli umani hanno cominciato a distinguersi dal resto del mondo animale non appena hanno cominciato a risolvere i loro problemi riproduttivi introducendo, nella loro sfera d’azione, anche elementi che non erano immediatamente percepibili con la loro preesistente sensibilità. Se poi hanno idealizzato questa capacità come un qualcosa di appartenente ad esseri sovrastanti, definendola come una “creazione”, è stato solo perché questa loro capacità ha preso corpo attraverso una generatio aequivoca, cioè più praticamente che consapevolmente. Certo, come sottolinea ripetutamente lo stesso Marx, le condizioni per poter affrontare il problema debbono esserci, ma non per questo debbono essere immediatamente date. Debbono piuttosto essere scoperte in un processo “nel quale la trasformazione delle circostanze fa tutt’uno con l’autotrasformazione di chi la attua”5.
Dov’è che i miei compagni di strada, che volevano riaffermare il bisogno di comunismo, mi hanno mollato, rendendo la mia anticipazione qualcosa di cui vergognarmi? Nel non riconoscere che, come aveva previsto Marx, e com’era stato anticipato da un conservatore come Keynes, il rapporto di lavoro salariato, nei paesi sviluppati, è ormai giunto al termine e giorno dopo giorno diventa sempre più difficile riprodurlo. Un modo di essere umani, che così tanto ha dato a tutti noi, si sta così dissolvendo. La conquista del punto zero corrisponde alla presa d’atto di questa dinamica in corso. Ma su di esso non si può far leva, se la proposta politica di redistribuire il lavoro, a parità di salario, viene affogata, in un contraddittorio affollamento con altri obiettivi salvifici (reddito di cittadinanza, decrescita, crescita degli investimenti dello stato, lavori socialmente utili, ecc.) che, costituendo delle scorciatoie, rendono la leva svantaggiosa, finendo col farci ripiombare sottozero, livello al quale ci troviamo oggi.
1. K. Marx “Il Diciotto Brumaio di Luigi Bonaparte”
2. K. Marx “Il Capitale” Editori Riuniti, Roma, 1970, pag. 89
3. K. Marx “Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica (Grundrisse)” Giulio Einaudi Editore Spa, Torino, 1977 Vol. I Pag. 296
4. K. Marx “Opere Complete” Vol. 1 Pag. 349 5. K. Marx 3° Tesi su Feurbach
* Giovanni Mazzetti è presidente dell’Associazione per la redistribuzione del lavoro. Già docente di Economia Marxista ed Economia del lavoro. Ha pubblicato numerosi testi sulla crisi con Dedalo, Datanews, Bollati Borighieri, Editori Riuniti, Asterios, Manifestolibri, Schirru, Punto Rosso, Rubbettino
Immagine da pxhere.com