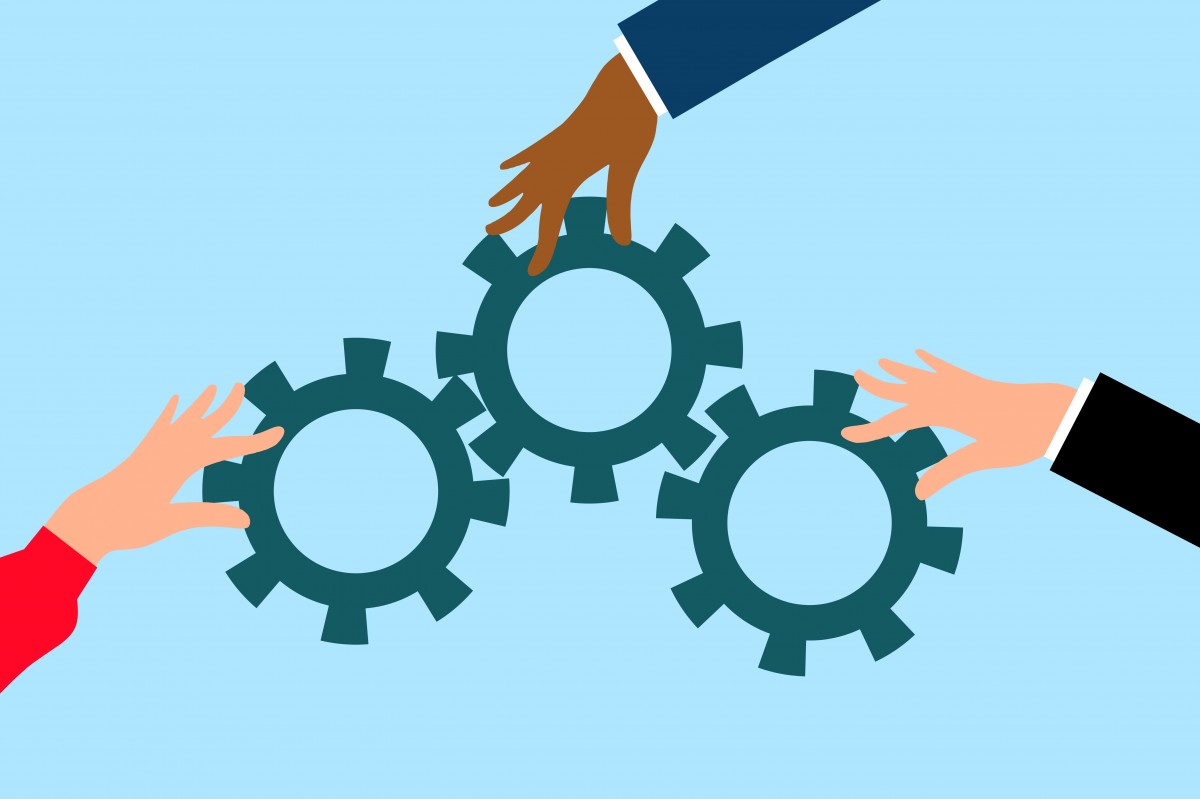Ricerca e futuro dell’Italia
Pietro Greco*
L’Italia è un paese che da almeno sessant’anni segue “un modello di sviluppo senza ricerca”. Lo dicono in molti, e in effetti i rapporti internazionali sulla competitività economica dimostrano che siamo un paese manifatturiero con forte capacità di esportazione nell’ambito delle medie e basse tecnologie, ma un paese che non produce e importa molto nel settore dell’hi-tech, delle tecnologie più avanzate. L’affermazione iniziale merita almeno due specificazioni. Il termine sviluppo implica due qualità (la sostenibilità sociale e la sostenibilità ambientale) che in genere i rapporti sull’economia non tengono in conto, mentre sono decisivi per la qualità della vita, e più in generale per il benessere di una popolazione.
In secondo luogo la parola ricerca va intesa come ricerca scientifica che, almeno dal secondo dopoguerra, è il motore della dinamica economica e la base su cui fonda, come avrebbe detto Adam Smith, la “ricchezza delle nazioni”. Se non fai ricerca non innovi, e senza innovazione l’economia ristagna. Se poi a questo aggiungi che la disuguaglianza aumenta da molti lustri, ecco che hai spiegato a grana grossa la crisi del nostro paese.
L’arretratezza italiana
La specializzazione produttiva del sistema paese ha consentito la crescita economica per alcuni decenni, dopo la Seconda guerra mondiale, quando il quadro economico e politico internazionale era assai diverso. L’Italia era nel novero ristretto dei paesi più avanzati, ed essendo il più povero tra i ricchi si è ritagliata una nicchia economica pagante col suo basso costo relativo del lavoro e con una moneta debole o resa artificialmente debole. Ma da almeno trent’anni – ovvero da quando è iniziata la cosiddetta “nuova globalizzazione” e da quando è caduto il muro di Berlino – la situazione è affatto diversa. Molti paesi, soprattutto nel sud-est asiatico, sono diventati protagonisti negli scambi internazionali di beni e di servizi. E se prima la scelta della crescita senza ricerca poteva funzionare, dalla metà degli anni ’80 del secolo scorso non funziona più. L’Italia paga un prezzo enorme alla incapacità di cambiare la specializzazione del suo modello produttivo.
Un indicatore forte di questa incapacità è la spesa nazionale in ricerca e sviluppo (R&S), ovvero nella ricerca scientifica e nello sviluppo tecnologico. Negli ultimi anni l’Italia investe in R&S circa l’1,3% del Prodotto Interno Lordo (PIL). A puro titolo di paragone: l’Unione Europa investe in media il 2,1%, la Cina il 2,2%, gli USA il 2,8%, la Germania il 3,0%, il Giappone il 3,2%, la Corea del Sud il 4,3%. Il mondo il 2,1%. I numeri parlano chiaro. Eppure fin dai primi anni duemila l’Unione europea aveva indicato a Barcellona (nel 2002) la strada per diventare leader nell’economia della conoscenza: investire almeno il 3,0% del PIL: l’1,0% da parte del pubblico, il 2,0% da parte dei privati.
Le statistiche dimostrano che la Germania e la gran parte dei paesi che dalle Alpi vanno fino alla Scandinavia lo hanno fatto, il resto d’Europa no. Anzi, i paesi mediterranei, Italia in testa, sono non solo molto lontani dall’obiettivo, ma non hanno mosso neppure un passo in avanti. Questo significa che tentano di galleggiare puntando più sul dumping sociale che sull’innovazione. E infatti il divario di reddito, e più in generale di diritti tra i lavoratori italiani e quelli del resto d’Europa, tende costantemente ad aumentare. Anche il sistema paese paga il suo pegno: la forbice tra il nostro PIL e la media europea cresce in media di un punto percentuale l’anno.
Ombre (tante), luci (poche)
Chi è che spende – o meglio, non spende – in R&S nel nostro paese? Un recente rapporto del Centro studi della camera dei Deputati ci offre un buon quadro della situazione. Già da prima della crisi da Covid-19, gli investimenti pubblici non solo non sono aumentati, ma sono addirittura diminuiti. Nel 2018, infatti, ammontavano ad appena lo 0,5% del PIL.
Situazione paradossale, perché i nostri ricercatori per lo più pubblici risultano tra i più produttivi e bravi da un punto di vista qualitativo del mondo. Tra i gruppi nazionali sono tra i primi quattro o cinque del pianeta, mentre il Paese è alquattordicesimo posto per spesa in R&S. Come è possibile? E fino a quando reggerà una tale asimmetria?
Gli scienziati italiani riescono come pochi a celebrare festose nozze con i fichi secchi. E il tavolo dove pranzano può contare su limitate ma decisive risorse internazionali, quelle europee in primis. Quanto alla seconda domanda è presto detto: la mancanza di risorse spinge i nostri giovani più bravi all’estero, dove sono accolti sempre con entusiasmo e schietto apprezzamento della loro preparazione e della loro creatività. Al contrario, grazie anche alle pericolose leggi sulla sicurezza varate in questi ultimi anni, noi respingiamo alla frontiera i pochi giovani stranieri che vorrebbero venire in Italia. Questo determina una perdita netta di “cervelli”. Ovvero una perdita netta per la cultura e l’economia del paese. L’Italia si impoverisce anno dopo anno.
E le aziende private? Il già citato rapporto del Centro studi della Camera dimostra che il settore investe in R&S lo 0,9% del PIL, e che l’80% di questi investimenti sono autofinanziati. Il paniere è poi riempito dall’11% di finanziamenti esteri e dal 5% di finanziamenti pubblici. Secondo i ricercatori del Centro Studi della Camera gli investimenti privati sono in crescita (anche se nel 2020 sono calati del 4,7%) rispetto al 2013, sia in termini assoluti che relativi. Ma … Ci sono due “ma”. Uno del tutto negativo, un altro tendenzialmente promettente.
Il primo “ma” negativo è che i 16 miliardi investiti dalle imprese italiane, pari a poco meno dello 0,9% del PIL, sono distanti non solo dagli obiettivi di Barcellona (2,0% del PIL) e dai risultati già conseguiti dalle imprese del nord Europa (le imprese tedesche, per esempio, hanno raggiunto l’obiettivo di Barcellona) ma anche dalla media europea che è pari all’1,4% del PIL. In altri termini non solo il nostro sistema produttivo conserva l’antica specializzazione produttiva e continua a seguire un modello di crescita (scarsa) senza ricerca, ma non mostra di voler o saper cambiare. Conseguenza di tutto ciò è che la crescita economica italiana è scarsa (eravamo in regresso rispetto al 2008 già prima del COVID) proprio perché senza ricerca.Questi numeri ci parlano della clamorosa sconfitta della strategia delle imprese nell’era della nuova globalizzazione: puntare sul dumping sociale invece che sull’innovazione di processo e soprattutto di prodotto è risultato perdente tanto per i lavoratori quanto per il sistema paese.
Già, ma chi deve e può realizzare il cambiamento di specializzazione produttiva? L’industriale che produce pipe in radica non può rinnovare la sua impresa e abbracciando l’optoelettronica: non sa neppure cos’è. O il ristoratore che rinnova latradizione di famiglia e offre buon cibo ai turisti non può trasformarsi in titolare di un’impresa di servizi avanzati. Occorre una nuova classe imprenditrice con la capacità di rinunciare a facili e pericolose scorciatoie (il dumping sociale) e di proporre produzioni fondate su nuova conoscenza. Occorrono giovani imprenditori attenti al sociale e capaci di innovazione.
Ecco dunque il secondo “ma”, piccolo ma promettente: poco meno del 4% degli investimenti in R&S nel 2019 è a opera di nuove imprese nei settori ad alto tasso di conoscenza aggiunto. Sono questi nuovi imprenditori, sono queste nuove imprese che vanno sostenuti: con o senza i soldi del Recovery Fund.
La sfida da cogliere
Come sostiene da tempo Sergio Ferrari, cha ha diretto per anni l’Osservatorio sull’Italia nel sistema tecnologico globale dell’ENEA (un ente pubblico di ricerca), è inutile finanziare l’innovazione di imprese tradizionali. Ed è inutile finanziare imprese che già puntano sulla ricerca. Nell’uno e nell’altro caso non c’è cambiamento. Occorre finanziare nuove imprese o imprese che realmente stanno cambiando.
Negli Stati Uniti il finanziamento alle imprese innovative avviene mediante capitali ad alto rischio (venture capitals) prestati da banche che hanno una specifica vocazione. In Europa e ancor più in Italia non ci sono queste banche. Tocca allo stato sia evocare nuove domande di beni e servizi ad alto tasso di conoscenza aggiunto nell’ambito di un’economia sostenibile sia aiutare i giovani che vogliono mettere a frutto le loro capacità.
È questa la sfida da cogliere. Perché è vero che la ricerca da sola non garantisce lo sviluppo (e neppure la crescita), ma è anche vero che non c’è crescita e ancor meno sviluppo senza ricerca.
* Pietro Greco è giornalista e scrittore. È stato per 25 anni editorialista scientifico dell’Unità. È stato consigliere del Ministro dell’Università e della Ricerca Fabio Mussi. Tra i suoi libri sul rapporto tra scienza ed economia: Contro il declino (Codice,2007) scritto con Settimo Termini; La risorsa infinita, scritto con Vittorio Silvestrini (Editori Riuniti, 2009); Con la cultura si mangia, scritto con Bruno Arpaia (Guanda, 2013).
Immagine da pxhere.com